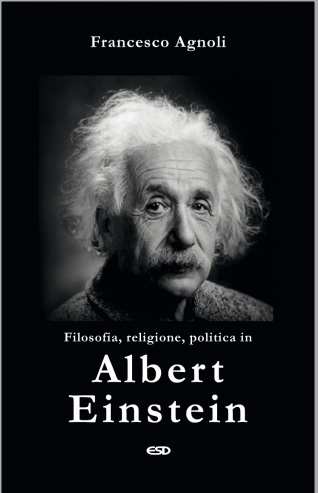 «Diversi autori riportano dell’allontanamento di Einstein dalla Bibbia e dalla fede ebraica, ma preferiscono tacere sul “ritorno”». Tra le tante, forse è stata questa la scoperta più interessante dell’ultimo lavoro dell’apprezzato scrittore e saggista Francesco Agnoli, intitolato Filosofia, religione e politica in Albert Einstein (Edizioni Studio Domenicano 2015).
«Diversi autori riportano dell’allontanamento di Einstein dalla Bibbia e dalla fede ebraica, ma preferiscono tacere sul “ritorno”». Tra le tante, forse è stata questa la scoperta più interessante dell’ultimo lavoro dell’apprezzato scrittore e saggista Francesco Agnoli, intitolato Filosofia, religione e politica in Albert Einstein (Edizioni Studio Domenicano 2015).
Si spiega, dunque, la compresenza di tante riflessioni di Albert Einstein su Dio, sulla morale, sulla mente creatrice dell’universo, ma anche sul rifiuto di un Dio personale, sul definirsi panteista (salvo poi scrivere la famosa frase: «Io non sono ateo e non penso di potermi chiamare panteista…»). La sua vita, come quella di tutti, è stata un percorso, non immune da frasi, posizioni e pensieri contraddittori. Tanto che Walter Isaacson, uno dei maggiori biografi del celebre fisico tedesco, ha scritto: «Per tutta la vita respinse l’accusa di essere ateo […], anzi, tendeva piuttosto ad attaccare gli atei, ad essere più critico verso gli scettici, che sembravano privi di umiltà e di senso di meraviglia» (W. Isaacson, Einstein. La sua vita, il suo universo, Mondadori 2008, p.376).
Quel che emerge dal volume di Agnoli è un profilo inedito del padre della relatività, appassionato di violino, che amava suonare nel convento francescano di Fiesole (Toscana) assieme a padre Odorico Caramelli, con il quale mantenne un rapporto epistolare anche negli ultimi anni di vita. Era di «una umiltà naturale e spontanea», ricordò padre Caramelli. «E se pure non era cattolico, andava volentieri in chiesa perché gli piaceva stare con Dio, in cui credeva. È venuto spesso a San Francesco. Prima mi ascoltava suonare, poi si decise e portò un violino e, strimpellando come sapeva fare lui, si faceva accompagnare da me all’organo. Di notte scendeva nel bosco del convento, e, seduto sul muricciolo della cisterna etrusca, suonava alla luna. Una volta, dopo che lo ebbi accompagnato in una Sonata di Bach, si commosse tanto che mi buttò le braccia al collo, quasi in pianto». Traspare bene la sua riverenza verso la filosofia, il desiderio di «risolvere il mistero dell’Universo», «il mistero che il libro della natura racchiude» (A. Einstein, L. Infeld, L’evoluzione della fisica, Bollati Boringhieri 2014, p.13-18). Nessun relativismo, è falsa la citazione “tutto è relativo” che gli si attribuisce, sempre Isaacson ha ricordato che «Einstein si sarebbe scandalizzato, e più tardi lo fu, della sovrapposizione di relatività e relativismo. Alla base di tutte le sue teorie, e anche della relatività, c’era una ricerca di invarianti, di certezze, di assoluti. Soggiacente alle leggi dell’universo, secondo Einstein, c’era una realtà armoniosa, e lo scopo della scienza era scoprirla» (W. Isaacson, Einstein. La sua vita, il suo universo, Mondadori 2008, p.9).
L’ebreo Einstein venne perseguitato dai nazisti, accusato oltretutto di una grave e singolare colpa. Lui, assieme al sacerdote cattolico Lemaître, al fisico cristiano Heinseberg, all’astrofisico quacchero Sir Eddington e a molti altri, sarà definito dai sovietici un “oscurantista”, reo di essere influenzato da una visione religiosa e biblica del cosmo, travestita da dottrina scientifica. Questo perché la nuova fisica e la nuova cosmologia disturbavano il materialismo dialettico e il pensiero di Democrito, promuovevano l’inizio della materia e dell’universo, la sua finitezza spaziale. Tanto che nel 1934, il fisico Ettore Majorana, scriverà: «con la nuova fisica la scienza ha cessato di essere una giustificazione per il volgare materialismo» (cit. in R. Finzi, Ettore Majorana: un’indagine storica, Storia e letteratura 2002, p. 48). Molto interessante anche la descrizione dell’amicizia tra Einstein e padre Lemaître, la stima e l’aiuto reciproco, tanto che il fisico tedesco sostenne la candidatura del sacerdote belga all’importante premio Franqui.
Certamente i capitoli più intensi sono quelli sul pensiero religioso di Einstein, formatosi nelle scuole cattoliche tedesche. L’allontanamento dall’ebraismo avvenne a causa dell’insofferenza delle prescrizioni farisaiche e da esperienze personali non positive, a cui seguì l’avvicinamento al panteismo spinoziano, alla «convinzione legata al sentimento profondo dell’esistenza di una mente superiore che si manifesta nel mondo dell’esperienza», che «costituisce per me l’idea di Dio» (A. Einstein, Come io vedo il mondo, Newton, 1984, p. 35). Nasce in lui la consapevolezza che «le idee più belle della scienza nascono da un profondo sentimento religioso, in assenza del quale resterebbero infruttuose» (citato in A. Pais, Einstein è vissuto qui, Bollati Boringhieri 1995, p. 112). Quello di Einstein, influenzato da Spinoza, non è un Dio Padre, un Dio personale che ha rivelato agli uomini una legge morale. Eppure, è al contempo appassionato de I Fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij, libro incentrato sul Dio cristiano. «Occorre evitare di considerare il grande scienziato un filosofo sistematico, sempre coerente, con una visione dell’esistenza statica nel corso degli anni», spiega Agnoli. «La domanda religiosa attraversa tutta la vita di Einstein, e la risposta non è sempre identica, né è sempre nitida e precisamente delineata» (p. 40). Spinoza lo conosceva superficialmente, arrivando a contraddirlo più volte come annotato dal suo amico e fisico cristiano Freeman Dyson, suo successore all’Institute for Advanced Study di Princeton: «Einstein fu una figura importante nella storia della scienza, e fu un fermo credente nella trascendenza» (F. Dyson, Lo scienziato come ribelle, Longanesi 2009, p. 30).
Il vero cambiamento avvenne nella terza fase della sua vita quando, come scrive Paolo Musso, docente di Filosofia della Scienza presso l’Università dell’Insubria, si osserva un «progressivo spostamento del baricentro della spiritualità einsteniana verso le grandi religioni storiche e in particolare verso la tradizione ebraico-cristiana» che giunge, «in alcuni momenti, addirittura a suggerire la necessità di una qualche sorta di rivelazione per fondare i valori morali e religiosi», e che convive con «l’originaria tendenza panteista» (P. Musso, La scienza e l’idea di ragione, Mimesis 2001, p. 263). Sono i drammatici fatti storici della sua epoca che convincono Einstein ad affermare l’uguaglianza tra gli uomini e una legge morale universale, quindi, di fatto, ad allontanarsi dal pensiero spinoziano, riappropriandosi delle sue origini ebree. Nel 1939 arriverà a scrivere: «I più alti principi su cui si fondano le nostre aspirazioni e i nostri giudizi ci vengono dalla tradizione religiosa giudaico-cristiana. Non c’è spazio in tutto ciò per la divinizzazione di una nazione, di una classe, e meno che mai di un individuo. Non siamo tutti figli di uno stesso Padre, come si dice in linguaggio religioso?». Lo scopo che ha il nazismo, «non è solo sterminare noi, ma insieme a noi distruggere anche quello spirito, espresso nella Bibbia e nel Cristianesimo, che rese possibile l’avvento della civiltà nell’Europa centrale e settentrionale» (A. Einstein, Pensieri, idee, opinioni, Newton 2004, p. 26 e 216). E’ Hitler a portarlo a riabbracciare le sue radici spirituali, rivaluta il pensiero teologico medievale e le scuole clericali, da cui nacquero le università e, commentando l’Antico Testamento e la storia del suo popolo, chiederà di «tenerci saldi a quell’atteggiamento spirituale nei confronti della vita». Perché l’«indebolimento del pensiero e del sentimento morale» odierno, causa «dell’imbarbarimento dei modi della politica del tempo nostro», è connesso all’indebolimento del «sentimento religioso dei popoli nei tempi moderni» (A. Einstein, Pensieri, idee, opinioni, Newton 2004, p. 22 e 212).
A Spinoza e Macchiavelli preferì Mosè e il libero arbitrio, elogiando la possibilità che l’uomo ha di «influenzare la propria vita e in questo processo possono avere una funzione il pensiero e la volontà coscienti». L’Einstein maturo, commenta Agnoli, alla fine di una serie di citazioni del pensiero del celebre fisico, «critica apertamente, benché implicitamente, il darwinismo sociale, l’idea secondo cui la vita morale dell’uomo si risolve, come nelle bestie, nell’obbedire all’istinto di sopravvivenza e nel partecipare alla lotta per la sopravvivenza del più forte; rinnega del tutto il determinismo tipico dell’evoluzionismo di stampo materialista e panteista ed afferma la libertà, contro il “fato crudele”, contro l’idea dell’uomo figlio dei suoi geni e della sua biologia, dell’inconscio, del determinismo materialistico, e di tutte le moderne riproposizioni del Fato e della Necessità antichi» (p. 118). Per cui, si può dire, che «certamente l’ Einstein della maturità è tornato ad assomigliare al giovane ragazzo infervorato dalla fede biblica, non senza che la passione per Spinoza, attraversata e continuamente rivista, mostri ancora la sua influenza» (p. 119).
Nel libro di Francesco Agnoli, recensito positivamente anche dall’Almanacco della Scienza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), viene inoltre ricostruito il rapporto del celebre fisico con il pacifismo militante, che rinnegò sopratutto perché spesso strizzava l’occhio all’ideologia marxista e sovietica, portandolo dopo il 1933 ad aderire al concetto di guerra “giusta”. Il noto saggista dedica anche molto spazio ai suoi colleghi (alcuni anche amici) scienziati (da Max Planck a Thomas Mann, da Kurt Gödel a Bertrand Russell), in particolare Arthur Eddington, a cui è dedicato un intenso capitolo, nel quale si ammira la profonda fede cristiana di uno dei più importanti astrofisici degli ultimi secoli. Una fede, non cristiana ma certamente biblica, che lo stesso Einstein ribadirà pochi giorni prima di morire, scrivendo alla famiglia del defunto amico Michele Besso: «Ecco che ancora una volta mi ha preceduto, seppur di poco nell’abbandonare questo strano mondo. Tutto questo non ha nessun valore. Per noi fisici credenti (für uns glaubige Physiker) la distinzione tra passato, presente e futuro si equivale ad una illusione, per quanto essa sia ostinata» (A. Einstein, Lettera alla famiglia Besso, 21/3/ 1955). Due mesi dopo, morirà anche lui.
La redazione
 “Sta venendo giù tutto”, “Bergoglio legittima il peccato”, “la Chiesa è alla deriva”. Sono alcune delle simpatiche e catastrofiche riflessioni del tradizionalismo cattolico, l’eresia che Papa Francesco ha avuto il merito di scoperchiare, speculare a quella progressista, contro la quale avevano a lungo parlato i suoi predecessori, Ratzinger e Wojtyla.
“Sta venendo giù tutto”, “Bergoglio legittima il peccato”, “la Chiesa è alla deriva”. Sono alcune delle simpatiche e catastrofiche riflessioni del tradizionalismo cattolico, l’eresia che Papa Francesco ha avuto il merito di scoperchiare, speculare a quella progressista, contro la quale avevano a lungo parlato i suoi predecessori, Ratzinger e Wojtyla.

 21 Aprile, 2016
21 Aprile, 2016




 Ironia del destino. Così si può definire la sorte di
Ironia del destino. Così si può definire la sorte di 
 Sessantasette anni fa nasceva
Sessantasette anni fa nasceva  Era in barella, non camminava da tempo, la paralisi alla gamba sinistra (a causa di una lombosciatalgia paralizzante) era totalmente invalidante. Si è immersa nella piscina di
Era in barella, non camminava da tempo, la paralisi alla gamba sinistra (a causa di una lombosciatalgia paralizzante) era totalmente invalidante. Si è immersa nella piscina di  Da un punto di vista prettamente storico-letterario, a partire dal 1700 il cristianesimo e le fonti cristiane, in particolare Bibbia e Vangeli, sono stati oggetto di un intenso studio da parte di ricercatori che si sono proposti di capire cosa ci fosse di effettivamente vero in queste fonti.
Da un punto di vista prettamente storico-letterario, a partire dal 1700 il cristianesimo e le fonti cristiane, in particolare Bibbia e Vangeli, sono stati oggetto di un intenso studio da parte di ricercatori che si sono proposti di capire cosa ci fosse di effettivamente vero in queste fonti.
 La mattina seguente all’attacco del Consiglio europeo all’Italia sulla presunta difficoltà di accedere all’
La mattina seguente all’attacco del Consiglio europeo all’Italia sulla presunta difficoltà di accedere all’ Con questo articolo siamo lieti di dare avvio alla collaborazione con don Silvio Barbaglia, biblista e docente di Scienze bibliche presso lo Studio teologico “San Gaudenzio” di Novara, istituto affiliato alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. Da poco ha pubblicato il volume
Con questo articolo siamo lieti di dare avvio alla collaborazione con don Silvio Barbaglia, biblista e docente di Scienze bibliche presso lo Studio teologico “San Gaudenzio” di Novara, istituto affiliato alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. Da poco ha pubblicato il volume 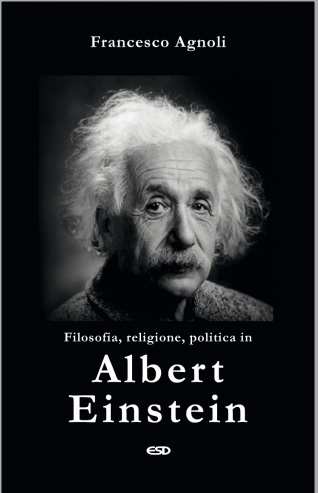 «Diversi autori riportano dell’allontanamento di Einstein dalla Bibbia e dalla fede ebraica, ma preferiscono tacere sul “ritorno”». Tra le tante, forse è stata questa la scoperta più interessante dell’ultimo lavoro dell’apprezzato scrittore e saggista Francesco Agnoli, intitolato
«Diversi autori riportano dell’allontanamento di Einstein dalla Bibbia e dalla fede ebraica, ma preferiscono tacere sul “ritorno”». Tra le tante, forse è stata questa la scoperta più interessante dell’ultimo lavoro dell’apprezzato scrittore e saggista Francesco Agnoli, intitolato