 Il procuratore nazionale Franco Roberti ha recentemente affermato: «Sono convinto che la Chiesa potrebbe moltissimo contro le mafie e gran parte delle responsabilità le ha proprio la Chiesa perché per secoli non ha fatto niente. Penso al discorso di Giovanni Paolo II fatto alla Valle dei Templi ma dopo quello? Silenzio assoluto. Zero reazioni, nonostante omicidi come quello di Padre Puglisi, fino al 2009 quando la Conferenza Episcopale ne parlò. Oggi dopo altri sei anni Papa Francesco ne parla apertamente e parla di scomunica».
Il procuratore nazionale Franco Roberti ha recentemente affermato: «Sono convinto che la Chiesa potrebbe moltissimo contro le mafie e gran parte delle responsabilità le ha proprio la Chiesa perché per secoli non ha fatto niente. Penso al discorso di Giovanni Paolo II fatto alla Valle dei Templi ma dopo quello? Silenzio assoluto. Zero reazioni, nonostante omicidi come quello di Padre Puglisi, fino al 2009 quando la Conferenza Episcopale ne parlò. Oggi dopo altri sei anni Papa Francesco ne parla apertamente e parla di scomunica».
Innanzitutto è difficile che la Chiesa non abbia fatto niente “per secoli”, dato che l’esperienza mafiosa per fortuna non copre il contesto temporale di oltre duecento anni. In secondo luogo, è una menzogna affermare che la Chiesa non abbia detto nulla fino al 1993, con il discorso di Giovanni Paolo II, e poi nulla ancora fino al 2009. E poi ancora silenzio fino ad oggi. Sono affermazioni sbagliate e gravi, tanto più se dette da un’autorità importante come quella di Roberti. La scomunica ai mafiosi è stata comminata numerose volte, soltanto l’episcopato siciliano lo ha fatto nel 1944, nel 1955 e nel 1982. Una critica a Roberti è arrivata da Tonio Dell’Olio, membro dell’ufficio di presidenza di “Libera”, l’associazione italiana contro gli abusi delle mafie.
Certo, ci furono episodi di omertà e di collusione di sacerdoti con la mafia ma non si possono dimenticare i continui pronunciamenti della Chiesa dagli anni ’50 in poi. Nemmeno si possono evitare di citare figure come il card. Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Palermo, nonché presidente della Conferenza Episcopale Siciliana e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana che unì la sua presenza pubblica a quella della aperta battaglia alla mafia. Proprio il card. Pappalardo spiegò che i ritardi nella comprensione del fenomeno mafioso furono all’epoca di tutta la società e di gran parte della stessa magistratura, non soltanto della Chiesa. Riconoscendo, certamente, che «non sempre, forse, nel passato sono state chiaramente percepite l’intrinseca gravità e le nefaste conseguenze tanto sociali che ecclesiali del fenomeno mafioso, fino a ingenerare l’impressione che certi diffusi silenzi o non troppo esplicite ed articolate condanne potessero essere segno di insensibilità o di tacita convivenza» (citato in M. Lancisi, “Don Puglisi, il Vangelo contro la mafia”, Piemme 2013). Tuttavia, specialmente dagli anni ’70 in poi, «non mancò la voce della Chiesa che di volta in volta condannava inequivocabilmente i delitti commessi e le oscure trame mafiose che ne erano all’origine. Anche se sulla loro consistenza, qualificazione ed estensione non si avevano allora le informazioni e le prove» divenute chiare soltanto all’inizio degli anni Ottanta, grazie ai pentiti.
La questione dunque non è così semplice come si vorrebbe far credere. Tuttavia, è sufficiente una veloce ricerca per scoprire che già agli inizi degli anni Cinquanta i vescovi italiani riuniti a Palermo per il primo sinodo del dopoguerra, bollarono i mafiosi come uomini senza morale e senza Dio.
Furono gli anni Sessanta, però, a far conoscere la mafia all’Italia intera, in particolare con la Strage di Ciaculli del 1963. In questo decennio effettivamente la Chiesa non ebbe ancora una chiara coscienza della portata del problema, ma d’altra parte nemmeno i media e lo Stato lo capirono. Come ha spiegato lo studioso Francesco Michele Stabile, «i vescovi non ebbero il coraggio di denunziare con chiarezza la incompatibilità tra mentalità mafiosa e professione di fede cristiana. La condanna morale delle azioni criminali, che sempre ci fu, non si esplicitava nella condanna della mafia come organizzazione criminale» (F.M. Stabile, “I consoli di Dio”, Caltanissetta-Roma 1999). Tuttavia due mesi dopo i fatti di Ciaculli, il sostituto della segreteria di Stato Vaticano, Angelo Dell’Acqua, inviò una lettera al cardinale Ernesto Ruffini, arcivescovo di Palermo, invitandolo a valutare se non fosse «il caso, anche da parte ecclesiastica, di promuovere un’azione positiva e sistematica con i mezzi che le sono propri – d’istruzione, di persuasione, di deplorazione, di riforma morale – per dissociare la mentalità della cosiddetta “mafia” da quella religiosa e per confortare questa a una più coerente osservanza dei principi cristiani, col triplice scopo di elevare il sentimento civile della popolazione siciliana, di pacificare gli animi e di prevenire nuovi attentati alla vita umana» (A. Chillura, Coscienza di chiesa e fenomeno di mafia, Palermo 1990). Nel 1964 il card. Ruffini, inizialmente poco cosciente del problema, intervenne con una lettera pastorale esponendo un excursus sull’origine dei termini “mafia” e “mafiosi”, riferendosi in particolare al mondo agricolo dove l’organizzazione nacque e aumentò il suo potere e criticando il fatto che gli abusi mafiosi sono divenuti «consuetudini perché tutelati dall’omertà degli onesti, costretti al silenzio per paura, e dalla debolezza dei poteri ai quali spettavano il diritto e l’obbligo di prevenire e di reprimere la delinquenza in qualsiasi momento e a qualunque costo».
Ma la pressa di coscienza avvenne nel decennio successivo. Sul sito web dedicato a padre Pino Puglisi, il sacerdote ucciso da Cosa nostra per il suo impegno sociale e antimafioso, si legge che durante gli anni Settanta una delle questioni centrali per la Chiesa siciliana fu proprio l’emergenza mafiosa e la collusione con essa di alcune correnti della Democrazia Cristiana, così come l’uso dei riti religiosi per legittimare davanti al popolo la propria potenza. Il 10 ottobre 1974 i vescovi siciliani pubblicarono un documento sui “mali sociali” dell’Isola, tra cui condannarono la «fosca macchia della mafia, che presume da una parte di risolvere i problemi della giustizia e dell’onore con le forme più grossolane e delittuose mentre, dall’altra, si accampa nei settori dell’industria edilizia e dei mercati con sistemi aggiornati di gangsterismo».
Gli anni Ottanta videro il cardinale Salvatore Pappalardo guidare la diocesi di Palermo (e ottenne la vicepresidenza dei vescovi italiani), lui stesso nel 1981 celebrò nel duomo quella che viene ricordata come la “Messa antimafia”, in cui si rivolse direttamente ai mafiosi dicendo: «Il profitto che deriva dall’omicidio è maledetto da Dio e dagli uomini. E quand’’anche riusciste a sfuggire alla giustizia degli uomini, non riuscirete mai a sfuggire a quella di Dio». Nell’autunno del 1982, dopo la strage di via Isidoro Carini, i vescovi siciliani spiegarono che la scomunica ai mafiosi colpisce non solo i responsabili diretti degli omicidi ma anche tutti coloro che collaborano. In occasione della morte del generale Dalla Chiesa da parte di Cosa Nostra, di fronte ai più importanti politici siciliani e italiani, il card. Pappalardo accusò violentemente la politica nella celebre “omelia di Sagunto”, che ha segnato una svolta nella lotta contro la mafia.
Non era certo una voce isolata, negli anni ’80 comparvero anche i cosiddetti “preti antimafia”, che istituirono centri sociali nei quartieri, in cui la popolazione povera e bisognosa riusciva a trovare un punto di appoggio. In questi centri prestavano e prestano tuttora servizio, come volontari e a titolo onorifico, sociologi, psicologi, teologi e medici, che offrono aiuto, sia materiale che ideale, con, ad esempio, svariati programmi di formazione e cultura. Obiettivo dei centri sociali era ed è promuovere, in maniera civile, una cultura politica e democratica che opponga resistenza alla penetrazione della mafia nella vita sociale. Nell’agosto del 1982 i parroci siciliani delle cittadine di Bagheria, Casteldaccia, Villabate e Altavilla Milicia (un quadrilatero particolarmente esposto alla mafia), decisero di lanciare assieme appelli dello stesso tenore: i mafiosi non sono gente d’onore ma trafficanti di droga e assassini su commissione, gente che un buon cristiano deve evitare come la peste. Nel 1983 don Giacomo Ribaudo, parroco di Villabate, riuscì a creare il Movimento Nuova Sicilia sollecitando i democristiani locali a presentare liste senza candidati in alcun modo associabili alla mafia. Nel novembre 1982 Papa Giovanni Paolo II si recò in Sicilia ma non pronunciò la parola “mafia” (i motivi non si conoscono), ma vi fece ampio riferimento nella visita a Palermo: «I fatti di violenza barbara che da troppo tempo insanguinano le strade di questa splendida città offendono la dignità umana…Occorre ridare forza alla voce della coscienza, che ci parla della legge di Dio».
Gli anni Novanta conobbero la durissima presa di posizione di Giovanni Paolo II, nel 1991 davanti ai diciotto vescovi della Sicilia parlò di “una Chiesa di frontiera” con la missione di avversare lo strapotere della Piovra (della mafia): «Come non condividere le vostre apprensioni per l’espandersi della criminalità organizzata di stampo mafioso, sempre più seminatrice di vittime e delitti? Tale piaga sociale rappresenta una seria minaccia non solo alla società civile, ma anche alla missione della Chiesa, giacché mina dall’interno la coscienza etica e la cultura cristiana del popolo siciliano. Nel corso di questi anni, di fronte a fatti di grave inquietudine, voi giustamente avete fatto sentire la vostra voce di pastori, preoccupati della sorte del gregge a voi affidato». Nel 1992 i vescovi italiani espressero ufficialmente nel Sinodo di Caltanissetta che «la scomunica dei mafiosi è latae sententiae, cioé automatica». Non occorre un pronunciamento formale, come una condanna o una incriminazione della magistratura. Si è quindi continuato: «La nostra Chiesa per combattere il fenomeno della mafia intende ispirare la sua azione al principio dell’incarnazione della fede nella storia concreta del nostro popolo, calandosi nella sua situazione con i suoi problemi, i suoi condizionamenti, i suoi valori». Dopo un invito ai sacerdoti ad agire con rinnovata incisività, i vescovi indicarono la parrocchia come «il luogo in cui chi subisce intimidazioni trova solidarietà e concreto aiuto per non soccombere», invitando i cristiani «a prendere le distanze dai mafiosi e spogliarsi dell’abito mentale mafioso che si concretizza principalmente nell’omertà, nel ricatto, nella sfiducia nel potere costituito, nel ricorso sistematico alle raccomandazioni, nella tendenza a costituirsi in gruppo di amici per gestire direttamente la propria difesa, nel distorto senso dell’onore, nella scarsa considerazione dei beni della comunità».
Il 9 maggio 1993 Giovanni Paolo II lanciò dalla Valle dei Templi di Agrigento il durissimo anatema contro la mafia, che ebbe anche il potere di convertire il sicario Salvatore Grigoli, omicida di don Puglisi. Nel novembre 1995 Papa Wojtyla ripetè il suo anatema alla mafia, parola per parola. Dalla metà degli anni ’90 in poi si cominciò anche a condannare pubblicamente la mafia puntando sulla sua inconciliabilità con il Vangelo, fino ad arrivare ai continui appelli degli ultimi 15 anni.
Don Luigi Ciotti, fondatore dell’Associazione Libera contro i soprusi delle mafie, ha ricordato recentemente: «c’è stata una Chiesa che ha sempre saputo essere attenta alle mafie. Magari numeri piccoli, ma c’erano sacerdoti e vescovi che condannavano questo male. Una Chiesa che ha reagito, ha parlato. Ma c’è stato anche chi per tiepidezza, prudenza, ignoranza, superficialità è stato dall’altra parte. Non possiamo nasconderlo, ci sono state delle risposte, dei sacrifici, del coraggio, ma anche dei grandi vuoti. Come Chiesa abbiamo un patrimonio molto importante, una storia fatta di storie. Certo con fasi alterne. E io sono andato a scoprire proprio queste oscillazioni della Chiesa in alcuni momenti attenta, in altri distratta». Ha comunque ricordato che fin dal 1877 il giornale “La Sicilia cattolica”, organo della curia vescovile di Palermo, denunciava la collusione tra la buona società e il crimine organizzato: «Che vale essere avvocato, sindaco, proprietario e perfino deputato se delle loro proprietà e titoli se ne servono a proteggere il malandrinaggio. Per giungere ad alcunché di positivo bisogna non transigere con la mafia». Ha commentato don Ciotti: «noi ne parliamo oggi ma qualcuno se ne era già accorto allora». Ha citato anche la scomunica dei vescovi siciliani del 1° dicembre 1944, «il testo ufficialmente non menziona il termine mafia, ma dal contesto si capisce che si riferisce a fatti e circostanza che riguardano la mafia. Dunque i vescovi siciliani c’erano già da allora su questi temi».
Dunque la storia come sempre è complessa, la Chiesa non ha taciuto mai semmai, a volte, ha scelto la prudenza, altre volte il silenzio, altre volte ha sottovalutato il problema. Ma, come ha detto il mafioso Leonardo Messina: «La Chiesa ha capito prima dello Stato che doveva prendere le distanze da Cosa nostra». Il procuratore Franco Roberti dovrebbe, perciò, indirizzare le sue accuse innanzitutto allo Stato, e citare meno riduzionisticamente e anticlericalmente la storia degli ultimi sessant’anni. Lo ha infatti criticato lo stesso don Ciotti: «Nella Chiesa noi abbiamo davanti agli occhi tanti esempi di chi vive il Vangelo con radicalità e senza accomodamenti. Pronti a dare la vita per combattere le mafie. Come è capitato in passato, capita oggi e capiterà in futuro. Se dobbiamo parlare di silenzi – che ad onor del vero nella Chiesa ci sono stati, comprese anche alcune connivenze – dobbiamo, però, parlare anche dei silenzi, delle complicità, delle reticenze, da parte di ampi settori della politica, della società civile e di organizzazioni istituzionali del nostro Paese che hanno colpe pesantissime. Questo è il vero problema. La Chiesa ha le sue fragilità ma anche testimoni bellissimi come don Pino Puglisi, per citarne solo uno».
La redazione

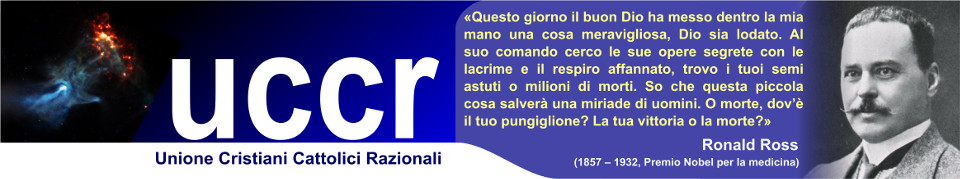

 5 Marzo, 2015
5 Marzo, 2015




 Si sostiene il matrimonio omosessuale parlando di discriminazione verso una relazione romantica basata sul reciproco consenso (love is love). Lo stesso si può dire anche di un gruppo poligamico. Se si apre alla nozze gay non si può più chiudere a nessuno e si distruggono le fondamenta del matrimonio.
Si sostiene il matrimonio omosessuale parlando di discriminazione verso una relazione romantica basata sul reciproco consenso (love is love). Lo stesso si può dire anche di un gruppo poligamico. Se si apre alla nozze gay non si può più chiudere a nessuno e si distruggono le fondamenta del matrimonio. Ci ritroviamo abbastanza spesso a svelare le ipocrisie e l’irragionevolezza delle tesi del cosiddetto “mondo di Repubblica”, quel sottobosco culturale guidato dal quotidiano diretto da Ezio Mauro, quasi inesistente nella società reale ma il padrone di casa nel mondo mediatico.
Ci ritroviamo abbastanza spesso a svelare le ipocrisie e l’irragionevolezza delle tesi del cosiddetto “mondo di Repubblica”, quel sottobosco culturale guidato dal quotidiano diretto da Ezio Mauro, quasi inesistente nella società reale ma il padrone di casa nel mondo mediatico. Ennesimo attacco a Papa Francesco da parte del giornalista di “Libero” Antonio Socci che, dopo un momento iniziale di curiosa attenzione mediatica, è sempre meno seguito e considerato. Noi preferiamo però proseguire a smontare i suoi ingenui e pretestuosi attacchi, dai feedback che riceviamo è un lavoro utile a molti che effettivamente ci hanno confessato essersi ritrovati intrappolati nel rancore dell’antipapismo, vivendo una dissociazione tra la fede cattolica e il cristianesimo adulto proposto dal tradizionalismo conservatore.
Ennesimo attacco a Papa Francesco da parte del giornalista di “Libero” Antonio Socci che, dopo un momento iniziale di curiosa attenzione mediatica, è sempre meno seguito e considerato. Noi preferiamo però proseguire a smontare i suoi ingenui e pretestuosi attacchi, dai feedback che riceviamo è un lavoro utile a molti che effettivamente ci hanno confessato essersi ritrovati intrappolati nel rancore dell’antipapismo, vivendo una dissociazione tra la fede cattolica e il cristianesimo adulto proposto dal tradizionalismo conservatore. L’offensiva mediatica e politica a favore dell’eutanasia in corso in Italia – che vede marciare compatto un organizzato schieramento che va da Le Iene al quotidiano La Repubblica, dal mondo radicale a quello di taluni cosiddetti vip, molto abili a maneggiare gli slogan – è sotto gli occhi di tutti. Decisamente meno visibili, quando non del tutto occulte, risultano invece essere le strategie costantemente impiegate per orientare il dibattito, e che vanno sempre più assumendo gli avvilenti contorni di una propaganda.
L’offensiva mediatica e politica a favore dell’eutanasia in corso in Italia – che vede marciare compatto un organizzato schieramento che va da Le Iene al quotidiano La Repubblica, dal mondo radicale a quello di taluni cosiddetti vip, molto abili a maneggiare gli slogan – è sotto gli occhi di tutti. Decisamente meno visibili, quando non del tutto occulte, risultano invece essere le strategie costantemente impiegate per orientare il dibattito, e che vanno sempre più assumendo gli avvilenti contorni di una propaganda. La Chiesa ed il rispetto delle donne. La musulmana Sabatina James, da sempre ribelle verso la legge islamica, lo riconosce e si converte. Oggi vive sotto scorta in Germania.
La Chiesa ed il rispetto delle donne. La musulmana Sabatina James, da sempre ribelle verso la legge islamica, lo riconosce e si converte. Oggi vive sotto scorta in Germania. è quella “la Chiesa vera”, è una chiamata interna, così si accosta ai grandi Padri della Chiesa, quali Agostino, Ignazio di Antiochia e Ireneo.
è quella “la Chiesa vera”, è una chiamata interna, così si accosta ai grandi Padri della Chiesa, quali Agostino, Ignazio di Antiochia e Ireneo. Sull’interessante sito web del noto filosofo e apologeta cristiano William Lane Craig è apparsa recentemente una domanda sull’utilità della
Sull’interessante sito web del noto filosofo e apologeta cristiano William Lane Craig è apparsa recentemente una domanda sull’utilità della  Il procuratore nazionale Franco Roberti
Il procuratore nazionale Franco Roberti  “La Chiesa si è comportata male“, “abortire è un diritto della donna”, “la laicità è un bene per la società”, “i cittadini hanno il diritto di scegliere come morire” ecc. Queste sono alcune delle affermazioni che spesso si sentono spesso dire da anticlericali e non credenti in Dio. Ma l’ateismo non riesce a giustificare l’esistenza di diritti umani oggettivi e assoluti.
“La Chiesa si è comportata male“, “abortire è un diritto della donna”, “la laicità è un bene per la società”, “i cittadini hanno il diritto di scegliere come morire” ecc. Queste sono alcune delle affermazioni che spesso si sentono spesso dire da anticlericali e non credenti in Dio. Ma l’ateismo non riesce a giustificare l’esistenza di diritti umani oggettivi e assoluti.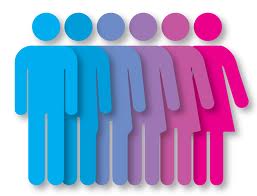 Il noto psichiatra americano
Il noto psichiatra americano