Alla fine, a cosa serve il cristianesimo?
- Ultimissime
- 13 Apr 2022
 A cosa serve il cristianesimo? Cosa ce ne facciamo del cristianesimo? Una bella riflessione di Ubaldo Casotto, la riprendiamo integralmente. Il cristianesimo non è una dottrina tra le altre, resiste nel tempo solo perché ha qualcosa da dire a me.
A cosa serve il cristianesimo? Cosa ce ne facciamo del cristianesimo? Una bella riflessione di Ubaldo Casotto, la riprendiamo integralmente. Il cristianesimo non è una dottrina tra le altre, resiste nel tempo solo perché ha qualcosa da dire a me.
di Ubaldo Casotto*
* giornalista
da Il Foglio, 14/01/22
«Le nostre società non sanno che farsene del cristianesimo».
Queste le parole di Alfonso Berardinelli in prima pagina su Il Foglio dell’8 gennaio scorso.
E poi, scrive ancora nell’incipit: «Se si volesse parlare chiaro, si dovrebbe cominciare a dire, per prima cosa, che il mondo attuale, o meglio l’occidente, cioè le nostre società e il nostro modo di vivere e di pensare, la nostra economia, tecnologia e politica, non sanno che farsene del cristianesimo».
Cosa serve una dottrina in più?
Berardinelli non cade nell’equivoco, in cui incorrono invece molti cattolici (e non solo) di identificare il cristianesimo con la cristianità, cioè con la civiltà (morale civile e sociale, ideologia, politica…) che ne è nata, ma che è ormai esperienza passata. Certo non liquidabile con sprezzatura (la cancel culture non è di casa in Vaticano, Francesco l’ha detto chiaro), però non è qui il cuore della questione.
Berardinelli ci invita alla lettura di Cristianesimo e modernità di Guglielmo Forni Rosa – lo farò – ed evidenzia la domanda a cui il libro vuole rispondere: in questa società una qualche forma di cristianesimo potrà ancora sopravvivere?
La forma individuata da Forni Rosa, che la deduce dalla lettura dell’Evangelii gaudium di Papa Francesco sarebbe quella di un «umanesimo fondato sul Vangelo», il quale «dovrebbe misurarsi con un cambiamento più o meno radicale dell’economia mondiale», che inevitabilmente implicherebbe, richiederebbe non solo un’etica ma una politica adeguatamente attiva, cioè una lotta.
Sono cresciuto con la convinzione che “militia est vita homini super terram”, non mi sono tirato indietro in università negli anni del terrorismo, né in seguito in battaglie culturali, politiche, giornalistiche e civili, ma non credo che fosse quella citata la lotta a cui si riferisce Giobbe. Per nominarla non trovo definizione migliore delle parole di Gesù Cristo riportate dall’evangelista Matteo “Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde sé stesso? Che darà l’uomo in cambio di sé stesso?”.
Il dramma, la lotta, sta qui. E sta qui – a mio parere – anche il possibile interesse del cristianesimo per l’uomo di oggi. La domanda di Berardinelli-Forni, d’altronde, era già quella di Fëdor Dostoevskij, che più di centocinquant’anni fa si chiedeva: “Un uomo colto, un europeo dei nostri giorni, può credere, credere proprio, alla divinità del Figlio di Dio, Gesù Cristo?”.
Il cristianesimo vive finché risponde alle esigenze ultime.
Può – ha risposto Joseph Ratzinger – finché il cristianesimo avrà qualcosa da dire di corrispondente. Oggi come in passato, alle domande ultime dell’uomo. Quelle domande che inevitabilmente riemergono nel più laico dei pensieri e nel più agnostico degli uomini, bucando la patina di cinismo o di nichilismo con cui ci proteggiamo dagli eventi.
Ad esempio, sulla giustizia. «Non me ne importa niente della prova dell’esistenza di Dio. Però, come Monod, ho questo sasso sullo stomaco: non accetto volentieri l’idea che il carnefice e la vittima scompaiano insieme nel nulla», ha scritto il filosofo Paolo Rossi.
Ad esempio, sulla speranza. «Io ero entrato in una notte senza fine, eppure nella parte più profonda di me persisteva qualcosa, molto meno di una speranza, diciamo un’incertezza […] persisteva l’idea che qualcosa nel cielo riprenderà la situazione in mano», come scrive in Serotonina Michel Houellebecq.
Ad esempio, sulla sofferenza e la morte, tornate protagoniste dei nostri timori negli ultimi due anni: come ricordatoci da una copertina dell’Espresso del dicembre 2020. «Avere paura del morire significa sapere che c’è qualcosa che trascende la nostra esistenza individuale. Un Fine. E gli Eredi».
Ad esempio, sulla felicità. «Sei felice in questo mondo moderno? O ti serve di più? C’è qualcos’altro che stai cercando?», come canta Lady Gaga.
La tentazione di vivere facendo a meno di Dio è vecchia come l’uomo, i primi a pensarlo e a farne una prassi sono stati Adamo ed Eva. Pilato fu campione di indifferenza con il suo beffardo “che cos’è la verità?”.
Gli illuministi, sulla scia di Kant – che ammetteva che «si può tranquillamente riconoscere che se il Vangelo non avesse insegnato le norme morali universali nella loro pura integralità, la ragione non li avrebbe conosciuti nella loro pienezza. Però, una volta che esistono, ciascuno può convincersi della loro validità attraverso la sola ragione» – tentarono di preservare i valori cristiani (alcuni sì altri meno) staccandoli dalla loro radice e forzando l’“etsi Deus non daretur” di Ugo Grozio.
I positivisti esclusero drasticamente Dio dall’orizzonte della ragione umana. I laicisti contemporanei concedono che possa esistere, ma “se c’è, non c’entra”, come icasticamente sentenziò Cornelio Fabro.
Invece c’entra. Non come dottrina che abbia la sua da dire in opposizione ad altre dottrine, ma perché ha qualcosa da dire a me.
Papa Francesco ripete spesso una frase: «Il cristianesimo non si propaga per proselitismo ma per attrazione». L’attrazione è un fatto umano. Occorre incontrare un uomo, o una donna, che si dice cristiano. Il grande regista russo Andrej Tarkovskij lo dice in modo forse insuperabile: «Tu lo sai bene: non ti riesce qualcosa, sei stanco e non ce la fai più. E d’un tratto incontri nella folla lo sguardo di qualcuno – uno sguardo umano – ed è come se ti fossi accostato a un divino nascosto. E tutto diventa improvvisamente più semplice».
E’ un metodo lento, ma pare sia quello scelto da Dio: un’ininterrotta catena di incontri che ha attraversato e continua ad attraversare la storia.











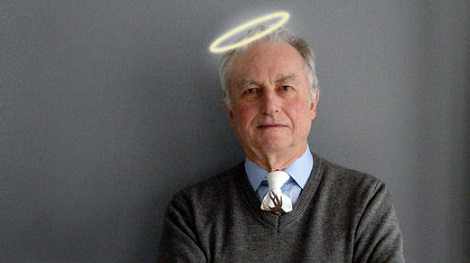

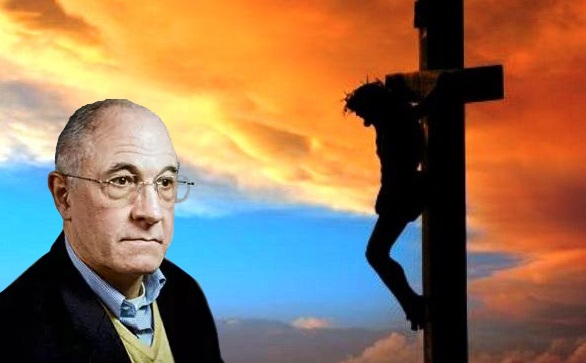


0 commenti a Alla fine, a cosa serve il cristianesimo?